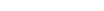Abstract
Giochi con regole private nell’esperienza compositiva contemporanea
La notevole fioritura di scritti teorici, di riflessioni estetiche, di dichiarazioni poetiche che, dagli inizi del Novecento, ha animato il dibattito sulle tecniche compositive, può essere considerata come segno dell'apertura di una nuova fase nell’esperienza musicale che ancora oggi può costituire motivo di interesse. Nei periodi che hanno preceduto le svolte innovative avviate agli inizi del secolo scorso, era stata ampiamente prevalente la situazione in cui la teorizzazione sulle regole della composizione seguiva o al massimo affiancava l'opera musicale; difficilmente la precedeva. Dall'affermarsi delle avanguardie novecentesche, la teorizzazione preventiva ha finito per prendere in molti casi il sopravvento, determinando, nei casi estremi, esempi evidenti in cui l'opera d'arte musicale ha rischiato di esaurire gran parte della sua ragione d'essere nella pura e semplice fase di ideazione teorica e progettuale.
La situazione che si è affermata nella proliferazione di regole e di linguaggi ad esse collegate, ha determinato spesso momenti di forte disorientamento nelle diverse esperienze, anche esse sempre più molteplici, che caratterizzano l’ascolto e la comprensione della musica.
Spesso si è reso plausibile il sospetto che la velocità di trasformazione della grammatica della musica, nel suo versante compositivo, sia stata troppo rapida rispetto alle possibilità di cambiamento ed evoluzione della percezione musicale.
Fenomeni estremi di attività autonormativa, parcellizzata in una molteplicità di regole sempre più riferibili non solo ad un singolo compositore ma addirittura ad una singola opera di un compositore, hanno avuto non di rado l’effetto di proiettare, se è lecito adottare un punto di vista di derivazione wittgensteiniana, la grammatica della composizione musicale fuori dalla prospettiva antropologica-prassiologica e dalla prospettiva antropologico-comunitaria.