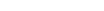Workshop
Andando a spasso fra i ricordi dell’infanzia si trovano a volte episodi sorprendenti. Igor Stravinskij racconta nelle Cronache della mia vita (1935) come, da bambino, fosse rimasto vivamente impressionato dal “canto” di un contadino, incontrato durante le vacanze estive nella verde campagna russa. Era un uomo robusto, dai rossi capelli, anziano e barbuto, con indosso solo una camicia: anch’essa rossa. Nei ragazzi suscitava un misto di curiosità e paura, ma non era cattivo. Tant’è che, quando i ragazzi si avvicinavano a lui, l’omone li intratteneva mettendosi allegramente a cantare. Un canto, racconta Stravinskij, composto da due sole sillabe prive di senso, accompagnate però da un suono che il contadino produceva così: «applicava la palma della mano destra sotto l’ascella sinistra, poi, con gesto rapido, faceva muovere il braccio sinistro appoggiandolo sulla mano destra». Ne usciva uno schiocco per nulla pudico, un suono avulsivo intessuto di brevi e ripetuti crepitii che tanto affascinarono il giovane Igor Stravinskij da indurlo a esercitarsi anche a casa nell’imitazione di quel canto sillabico comitante axilla: i genitori esterrefatti, lasciarono al figliolo il canto, ma vietarono l’accompagnamento ascellare.
Nel lungo cammino antropogenetico accade che il suono talora sia confuso col rumore e talaltra se ne affranchi. Questa vicenda di abbandoni e ripulse, contagi e prese di distanza accompagna quell’altra vicenda, nella quale noi tutti siamo sempre compresi: l’animale e l’uomo, il vivente sprovvisto di linguaggio e quello che il linguaggio invece possiede. Ciò che chiamiamo musica non può che pensarsi sullo sfondo di ciò che – per sempre talvolta, o per un tempo determinato – dal suono è collocato a distanza, atetizzato. Ogni tentativo di raccontare l’esperienza del suono non può prescindere dalla presa d’atto di questa cesura, dal fatto che essa c’è stata, e che il suono musicale, per essere ascoltato, deve non più essere quel che semplicemente viene udito. Il poeta greco Alcmane andava, come Stravinskij nella sua Russia, per i boschi dell’Argolide e della Laconia, a ricercar le voci degli uccelli, per farne materia di canto. Alcmane, però, non aggiunse parole alla voce, semmai (come diremmo oggi) “laconicamente” fu spinto a sottrarne, come faranno dopo di lui antichi e moderni, poeti, rapsodi e raccoglitori di canti.
“Di ciò di cui non possiamo parlare, occorre tacere”. E la musica, in questo senso, non fa che tacere. Da millenni essa tace, appunto, di ciò di cui non possiamo parlare. È, in certo modo, la sceneggiatura di questo silenzio che – al di là o al di qua di ogni semantica linguistica – viene a far da contrappunto alla parola. Talora, tuttavia, questo silenzio ha il potere di suscitare altro da sé: la musica tace quanto alla parola, ma illustra quel che la parola non dice; non riduce al silenzio la parola, ma, rende questo silenzio visibile in quanto silenzio-della-parola. La musica non è reticenza, bensì figura dell’aposiopesi. Essa si tace, come, secondo il racconto di Plutarco, i Greci facevano al passare del dio Hermes.
La parola che è stata qui convocata in un Seminario dal titolo lunghissimo [Forme dell'inferenza e logiche della prassi nell'esperienza musicale] è la parola del filosofo. Come Alcmane, il filosofo conosce i suoni delle creature volatili e sa parlare parole alate, épea pteròenta; parole, cioè, che come frecce raggiungono il loro bersaglio. Egli si trova a convivere con la determinatezza del riferimento semantico e con la vaghezza (o polisemia) del “riferimento” musicale. Che dirà il filosofo dinanzi al panorama della musica che gli si offre oggi alla vista? Il suono è oggi pervasivo, inclusivo, esclusivo. Le voci sono non più solo naturali o artificiali, ma anche digitali, virtuali; la pratica stessa dell’ascolto non è più solo cerimonia o rito o salotto, ma introiezione auricolare a mezzo di iPhones. E gli spazi nei quali è collocata la musica sono, da una parte, sempre più numerosi, ma dall’altra, sempre meno riconoscibili in quanto luoghi. La musica dei non-luoghi obbliga il filosofo a comprendere che ne sia oggi di quella creatura che Adorno chiamava “l’omino della metropolitana”. Dove si situa la soggettività del musicale oggi? E che dire di questa soggettività nell’era della sua riproducibilità virtuale? A tutto questo attenderanno gli oratori invitati a dialogare nel nome della musica e dell’amicizia che essa può suscitare nel cuore dell’uomo. Ospite d’onore del nostro moderno Convito è Giovanni Piana, filosofo che alle facili certezze dogmatiche ha preferito il laconico ritrarsi nella ricerca silente, operosa, ricca di suoni. A tutti il più amabile benvenuto nella città di Macerata e nella sua bella Università.
marcello la matina